Il risultato di un progetto di ricerca multidisciplinare che ha coinvolto storici, antropologi, filosofi, semiologi, storici dell’arte
Frutto del PRIN 2015 “Cucina Politica” che comprende UNISG, Università di Bologna e Università di Palermo
Da Pollenzo contributi di Nicola Perullo, Antonella Campanini, Maddalena Borsato e Elena Mancioppi.
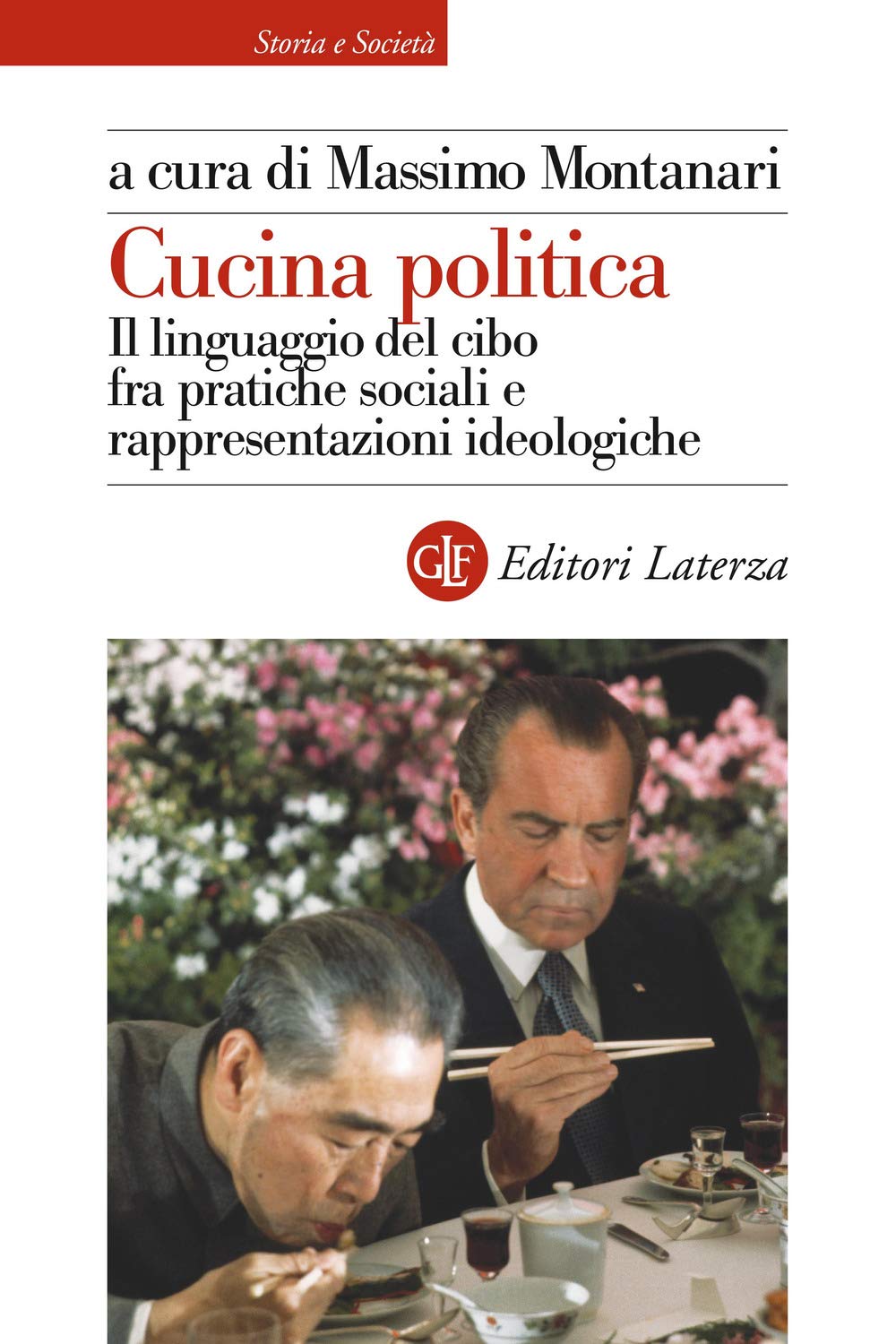
È uscito a gennaio 2021, per i tipi di Laterza e a cura di Massimo Montanari, “Cucina Politica – Il Linguaggio del cibo tra pratiche sociali e rappresentazioni ideologiche”, un ricco e variegato volume, risultato di un progetto di ricerca multidisciplinare che ha coinvolto storici, filosofi, semiologi.
Il libro raggruppa 21 saggi redatti da altrettanti studiosi italiani e stranieri – facenti capo agli atenei di Bologna, Palermo e Pollenzo- che attraverso i rispettivi ambiti di studio, analizzano la dimensione politica del linguaggio alimentare, in due direzioni. In un senso si guarda al cibo come segno di appartenenza a una comunità, capace di definire l’identità di gruppi sociali, economici, culturali, religiosi. Dall’altro si guarda alle azioni promosse dai pubblici poteri per garantire sicurezza alimentare ai cittadini.
Il volume è frutto del progetto di ricerca PRIN 2015 “Cucina Politica”, la cui responsabilità scientifica per l’unità di Pollenzo è stata di Nicola Perullo, professore ordinario di Estetica e Prorettore dell’ateneo, e che ha coinvolto anche Antonella Campanini, ricercatrice in Storia medievale, Maddalena Borsato e Elena Mancioppi, dottorande in Ecogastronomia, Formazione e Società.
Nel corso della ricerca triennale, l’UNISG ha organizzato convegni e conferenze, oltre ad avere partecipato a incontri di divulgazione sul tema.
In particolare ricordiamo la tavola rotonda “Cucina Politica: ospitalità, convivialità, diplomazia” tenutasi l’11 giugno 2017 nella cornice del Migranti Film Festival, coordinata dal prof. Nicola Perullo e con la partecipazione di Luigi Maria Vignali, Ministro plenipotenziario e Direttore generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie (DGIEPM), Francesco Mangiapane, semiologo dell’Università di Palermo, Soumaya Abdel Qader, già consigliera comunale Città di Milano, Abderrahmane Amajou, responsabile area tematica Migranti Slow Food Internazionale, e Francesca Peirotti, attivista associazione Habitat et Citoyenneté di Nizza.
E anche il convegno “Educare attraverso il cibo: modelli e pratiche tra Università e Comunità” del 20/21 giugno 2019, svoltosi a Pollenzo con Nicola Perullo, Massimo Montanari, Gianfranco Marrone, Jan Masschelein, Leszek Koczanowicz e molti altri relatori.
Massimo Montanari, professore di Storia dell’Alimentazione all’Università di Bologna, così scrive nell’introduzione del volume: “Il cibo è una forma di linguaggio, che, al di là del suo valore nutrizionale, significa e veicola idee e messaggi di straordinaria forza espressiva, quale solo gli oggetti e le pratiche d’uso quotidiano possono avere. Idee e messaggi che cambiano nello spazio e nel tempo, come tutte le espressioni culturali, che, pur caratterizzate da costanti e continuità sul piano storico e geografico, si declinano in modo diverso a seconda dei contesti. Questo volume intende mettere a fuoco la dimensione politica del linguaggio del cibo, in due direzioni principali. Da un lato, la funzione del cibo come segno di appartenenza a una comunità, l’essere e sentirsi cittadino di quella che i Greci chiamavano una polis. Dall’altro, i discorsi e le immagini che accompagnano le azioni alimentari messe in opera dai pubblici poteri per gestire e definire il rapporto con i cittadini (o i sudditi),”
Conclude Montanari: “Cucina politica ci è parso un bel titolo, semplice e chiaro, per sintetizzare tutto ciò. Lo abbiamo preso a prestito da un film del 2004, Politiki kouzina, del regista greco Tassos Boulmetis, che suggerisce entrambe le prospettive, sia nella trama, sia nel titolo. Il racconto si dipana in un contesto geopolitico difficile, quello del conflitto greco-turco e della deportazione dei greci di Istanbul, dove anche un ‘tocco di zenzero’ (è questo il titolo del film nella versione italiana) può servire a richiamare affetti familiari e valori di identità collettiva. Ed è polivalente il senso di politiki, che indica l’azione di governo, la politica in senso stretto, ma anche l’appartenenza alla polis cioè alla città e in questo caso alla polis per eccellenza, Costantinopoli. Insomma un gioco di specchi linguistico che ci è parso ideale per esprimere la complessità di prospettive della nostra cucina politica”.
Nel volume si possono leggere i contributi dei docenti e ricercatori dell’UNISG: in ordine di apparizione, nella sezione “Assaggi Storici” troviamo Antonella Campanini con “I banchetti come rituale politico (secoli XV e XVI), quindi nella sezione “Assaggi semiotici e filosofici” le dottorande Maddalena Borsato con “Il gusto come senso estetico-politico” e Elena Mancioppi con “L’olfatto come senso estetico-politico”. Chiude il volume il saggio di Nicola Perullo, “Cucinare come educazione estetica e politica”.
Tra i saggi della sezione storica, anche il contributo “Ricette o politica”, di Alberto Capatti, che è stato il primo rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche.



