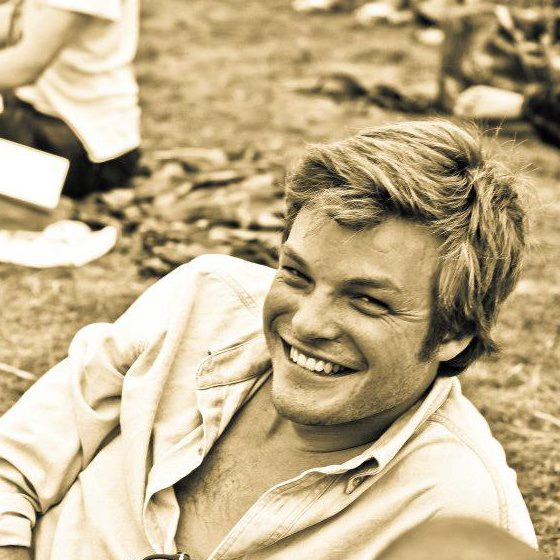Premessa
Quello che viene qui proposto è il 5° capitolo della mia tesi di laurea specialistica in Antropologia Culturale ed Etnologia, dal titolo “Vent’anni di immigrazione marocchina a Dogliani – Flussi, consolidamento e adattamento alla crisi di una comunità immigrata in un centro della bassa Langa cuneese” e discussa nel 2012 con il prof. Pierpaolo Viazzo presso l’Università di Torino.
La tesi traccia la storia di vent’anni di immigrazione marocchina a Dogliani, un piccolo comune della bassa Langa cuneese.
Sono stati analizzati – attraverso lo studio dei dati anagrafici relativi ai cittadini marocchini residenti a Dogliani dal 1990 al 2010 – i flussi di arrivo degli uomini soli, quindi i ricongiungimenti familiari, il consolidarsi dell’insediamento e l’adattamento alla crisi economica che ha investito il distretto produttivo doglianese negli anni Novanta e Duemila.
In questa ricerca si è evidenzato come la comunità marocchina doglianese sia stata dapprima il frutto di un esodo rurale dalle campagne dell’interno del Marocco verso le città della costa dove l’industria aveva avuto uno sviluppo negli anno Settanta, quindi di una migrazione verso l’estero, in questo caso particolare Dogliani.
La ricerca ha provato, attraverso la lettura e il confronto di vent’anni di dati forniti dall’Ufficio Anagrafe, che le reti migratorie sono in larga parte a base familiari oppure legate al douar (piccolo insediamento rurale sulla base di antica appartenenza tribale).
La tesi si proponeva, attraverso una serie di interviste, di corroborare con testimonianze di prima mano l’evidenza che emergeva dai dati anagrafici (esodo rurale, reti migratorie e legami parentali), quindi di verificare il bisogno della comunità di darsi un’identità precisa e marcata legata ai concetti di cibo, rituale e memoria, oltre ad una forte connotazione religiosa.
Gli spazi della produzione e consumo del cibo e della vita quotidiana all’interno dell’abitazione marocchina, in Marocco e in Italia
Come già anticipato nel capitolo introduttivo, inizialmente il mio progetto di ricerca sulla comunità marocchina doglianese avrebbe dovuto focalizzarsi sul binomio cibo-identità. Ovvero come il cibo fosse una componente fondamentale nella ri-costruzione della propria identità in un nuovo paese: e anche come il cibo fosse un legame importante con il proprio paese di origine, in riferimento alle dinamiche familiari e sociali all’interno della comunità.
Le interviste che ho condotto hanno sempre avuto come punto di partenza il focus sul cibo. Dove possibile, ho cercato di far parlare sia il marito che la moglie per cercare di capire le relazioni all’interno della coppia, così come il rapporto di ognuno dei coniugi nei confronti del cibo, ma soprattutto della sua preparazione.
Nella maggior parte dei miei incontri, vuoi per interviste concordate o per chiacchierate informali, mi sono fatta illustrare le abitudini culinarie dei vari membri della famiglia, quindi ho posto domande sull’approvvigionamento di prodotti tipici per la preparazione di piatti tradizionali marocchini, e poi ho cercato di capire il valore emozionale e affettivo del cibo per loro.
Le mie supposizioni sono dunque state confermate dalle testimonianze e dalle frequentazioni.
Condividere il pasto con una famiglia marocchina, inoltre, significa capire molte cose delle dinamiche sociali e dei rapporti tra i sessi.
Ho potuto verificare personalmente che cosa significhi essere ospite e condividere un pasto in Marocco, presso la famiglia di origine (in genere si tratta di famiglia allargata), e che cosa significhi, invece, condividere un pasto presso una famiglia marocchina qui in Italia.
Talvolta, presso alcune famiglie o in occasioni particolari (nascite, circoncisioni, matrimoni), le modalità sono le stesse sia in Italia che in Marocco. Più spesso, invece, si tende a “rimarocchinizzarsi” quando si torna al paese, e ad adottare abitudini del paese ospitante quando in Italia.
È esemplare spiegare come si svolga un pasto con uno o più ospiti “esterni”, ovvero non appartenenti alla famiglia. A questo proposito posso portare alcuni esempi relativi a mie trasferte in Marocco in occasione di matrimoni o feste per la circoncisione di bambini.

Cous Cous di verdure – Elisa Mereatur
In linea generale, all’interno di famiglie piuttosto numerose che, nella stessa casa oltre a marito, moglie, figli, talvolta raggruppano anche suoceri, cognati o altri parenti, vige la regola dei pasti separati per gli uomini e per le donne. In quanto ospite esterno e accompagnata da un partner maschile (nel mio caso dal mio allora futuro marito), pur essendo donna, molte volte sono stata invitata alla tavola maschile.
Essendo considerata ospite di riguardo il mio genere sessuale veniva in secondo piano e, insieme al mio compagno, ero assimilata agli uomini. Spesso alla tavola maschile erano ospitati anche i bambini, e talvolta anche le donne più anziane.
In famiglie dove i coniugi avevano uno stile di vita urbano e il nucleo era ristretto, invece, generalmente si mangiava tutti insieme (in questo caso, più che ospite di riguardo, diventavo invece una della famiglia, una “sorella”).
La dinamica della segregazione sessuale in occasione dei pasti viene a infrangersi una volta l’immigrato si ritrova, con la famiglia nucleare, in terra italiana. In Italia, infatti, la conformazione stessa delle abitazioni (si tratta per la maggior parte di appartamenti in palazzi o condomini, in cui diventa difficile ricreare gli spazi della tipica casa marocchina), così come il numero limitato del componenti familiari, non favorisce questa abitudine.
Occorre qui fare una breve digressione sulla struttura della casa marocchina classica.
Durante i miei viaggi in Marocco, effettuati a più riprese dal 1993 al 2010, ho avuto modo di visitare diverse abitazioni, e grosso modo tutte avevano caratteristiche simili. Il fulcro della casa è il grande salone comune, il cui perimetro è costeggiato da divani: si ricordi che il tradizionale divano marocchino funge da seduta e anche da letto per la notte, quindi il salone è luogo pubblico per eccellenza durante il giorno, ma grazie alla conformazione delle sedute, può essere usato per dormire da più persone contemporaneamente. Nella maggior parte dei casi ci dormono i bambini.
Nella case marocchine tradizionali non esiste quella che per noi europei è la camera da letto: o meglio, esiste solo per la coppia di sposi (e non sempre) e si trova principalmente nelle abitazioni di costruzione recente che si stanno omologando al gusto europeo o nelle unità abitative modello HLM francesi, le habitations à loyer modéré da noi note come “case popolari” che si trovano nelle periferie di alcune grandi città.
C’è poi una cucina, di dimensioni ridotte e adibita specificamente alla preparazione del pasto (ma non al suo consumo), quindi un bagno (quando c’è) piuttosto piccolo, spartano e con funzioni quasi esclusive di toilette.
Alla cura e alla pulizia del corpo è infatti riservato lo spazio collettivo dell’hamman del quartiere (bagno turco pubblico, con orari o giorni diversi per uomini e donne). Nell’abitazione ci sono anche altre stanze, sempre sul modello del salone centrale, adibite al riposo notturno o pomeridiano.
Fondamentale è poi la terrazza, nel caso in cui si tratti di abitazione singola o bifamiliare. Uno spazio, questo, che è tanto quanto la cucina un dominio femminile, talvolta dedicato al relax, e spesso nelle afose notti estive anche luogo per il riposo.
Nel cuore delle varie medine, non c’è quasi soluzione di continuità tra una terrazza e l’altra, per la stretta vicinanza delle costruzioni. Le donne si scambiano confidenze e pettegolezzi mentre stendono la biancheria, i bambini giocano, gli adolescenti si adocchiano e cercano i primi contatti tra sessi diversi fuori dal controllo familiare (Mernissi, 1996). Talvolta si può fisicamente passare da una terrazza all’altra, basti pensare al film di Gillo Pontecorvo La battaglia di Algeri, dove i resistenti algerini trovavano rifugio nelle varie case saltando tra i tetti.
Tutto questo in Italia non esiste più: difficile ricreare il salone marocchino, cuore della casa e della convivialità, impossibile avere un tetto a terrazza, a maggior ragione in una regione fredda e nevosa come il Piemonte. Inoltre la famiglia è diventata nucleare, e pur se numerosa, il nuovo stile di vita impone comunque una privacy diversa. I ragazzi crescono “italiani”, come i loro coetanei vogliono la cameretta, con il computer e la scrivania, mentre i genitori iniziano ad apprezzare la riservatezza di una stanza da letto solo per loro.
Fatta questa premessa che ci ha aiutato a capire come si svolge la vita all’interno di una casa marocchina, in Marocco e in Italia, e quali sono le differenze spaziali che hanno inciso cambiamenti nella vita intima e in quella sociale di queste famiglie di immigrati, è necessario sottolineare che quanto descritto in questa ricerca si riferisce a quello che ho potuto osservare in questi vent’anni sia in Marocco che a Dogliani e in altre zone della provincia di Cuneo: tuttavia ho buone ragioni per pensare che questi processi di adattamento siano comuni anche in altre zone del Piemonte e dell’Italia, dove esistono comunità marocchine in centri di piccole e medie dimensioni.
Il cibo “marocchino” in Italia
Come già detto, uno dei filoni di analisi della comunità marocchina doglianese è anche stato il cibo inteso come legame con il paese natale e le tradizioni familiari e come strumento di affermazione della propria identità (vogliamo dire etnica? oppure religiosa? o di appartenenza ad una certa cultura? per chi scrive si tratta di un mix di tutte e tre le connotazioni).
Negli anni di frequentazione quasi quotidiana in occasione di pranzi, cene, merende e festività condivise, sia a Dogliani che in Marocco, ho potuto osservare alcune costanti che si ripetono in ogni famiglia di immigrati che ho conosciuto.
In primo luogo la ricerca dei sapori “beldi” (nostrani, del paese) attraverso l’approvvigionamento di prodotti provenienti dal paese natale e/o la ricerca di prodotti simili nella terra d’adozione (rispettivamente portando con sé di ritorno dalle vacanze grandi quantità di prodotti acquistati da fornitori di fiducia in Marocco, e facendo riferimento in Italia ad attività commerciali gestite da compatrioti – ma non esclusivamente – che vendono prodotti della madre patria); quindi la necessità di una legittimazione della ritualità attraverso la ricerca di macelli autorizzati e l’importanza della dimensione conviviale ed emozionale legata alle ricorrenze religiose e celebrazioni familiari.
Un altro aspetto che ho voluto sondare, soprattutto per capire che cosa era cambiato all’interno della comunità marocchina doglianese rispetto ai primi anni del suo insediamento (anni Novanta, con riferimento anche alla ricerca condotta da Sappa nel 1991) è quello del mutamento e ripristino dei ruoli di genere all’interno della casa. Quando l’immigrazione era principalmente maschile, nella cucina di casa erano gli uomini soli a confrontarsi con i fornelli, e a fare necessariamente ricorso alle rimembranze di savoir faire femminile apprese nel foyer materno. Con il ricongiungersi dei nuclei familiari, l’uomo “riprende il suo posto” e in cucina arriva la donna. Quello che ho cercato di indagare è stata anche la differenza tra la cucina “maschile” e quella “femminile”.
Insomma, alla luce degli elementi complessivi a mia disposizione ho tentato di interpretare i differenti ruoli in cucina come lente per leggere il mutamento della struttura familiare. Diciamo che in questo ventennio analizzato si è assistito ad un riequilibrio e un ritorno alla formula familiare tradizionale: l’uomo al lavoro e poi al caffè o in moschea, la donna in cucina, quindi al mercato e nei saloni di casa per ritrovi esclusivamente femminili.

Tajine di agnello con uova e prugne – Mario Traina
Il modello di famiglia marocchina classica è ricostituito: almeno fino a quando le seconde generazioni non iniziano a rivendicare nuove abitudini ed esigenze.
Sui gusti alimentari dei ragazzi di seconda generazione si potrebbe aprire un capitolo a parte, ma si tratta di un altro discorso, troppo lungo e complesso per poter essere affrontato qui: basti solo sapere che, in ogni famiglia che conosco o che ho personalmente visitato almeno una volta, le mamme hanno imparato a preparare alcuni piatti chiave della cucina italiana per soddisfare il palato e le richieste dei loro figli.
Pizza e focaccia, pasta al sugo, pasta al forno (lasagne), sono tra le specialità più amate. Piaccia o meno, ormai, non possono mancare nel menù quotidiano della comunità marocchina doglianese. A questo proposito un episodio che mi riguarda personalmente è esemplare.
A. (il bimbo della mia ex tata) è uno dei migliori amici di mio figlio: talvolta viene a giocare da noi, così come noi spesso andiamo a trovarlo. Quando mio figlio è in visita da “mamma S.”, si catapulta felice in salone dove sa che potrà bere due o più bicchierini di tè alla menta, accompagnati da crêpes e focaccine appena sfornate. Allo stesso modo, A., suo “fratello”, quando è possibile rimane da noi per cena con una richiesta ben specifica: “gli spaghetti al pomodoro come li sai fare tu”. Più di una volta A. mi ha chiesto la ricetta perché vuole che anche la mamma glieli prepari.
Trovo significativo questo incrocio di sapori e di preferenze: di chi, anche se di origine italiana, è stato allevato a tè alla menta e ogni qual volta può lo cerca, e di chi, anche se di origine marocchina, ha messo in cima alla liste delle cose buone un piatto di pasta con pomodoro fresco.
Veniamo ora ad analizzare le modalità di preparazione del cibo come chiave di lettura di diverse dinamiche familiari. In riferimento a quanto esposto all’inizio del paragrafo, possiamo ritrovare similitudini con l’analisi di Rosa Parisi (2006):
In generale, i Marocchini in Italia, sia quelli sposati con italiani o con altri Marocchini, nella quotidianità, usano ingredienti e modalità di preparazione dei cibi della cucina italiana. Tale scelta è dettata dalla difficoltà di reperire ingredienti della cucina marocchina, in particolare le spezie, ma anche per la lunghezza dei tempi di cottura di alcune pietanze che renderebbe difficile armonizzare i tempi del lavoro con quelli dedicati all’alimentazione. (…) Molte volte, le pietanze della cucina marocchina – stufati di carne di montone o agnello cotti nel tajin – sono riservate ai pasti del fine settimana, compreso il venerdì, il giorno dedicato alla preghiera in moschea, o a quelli consumati nelle occasioni in cui si invitano gli amici a casa o nelle occorrenze festive. (…) In Marocco, più che in Italia, le attività nella sfera privata-familiare sono affidate quasi esclusivamente alle donne: la divisione delle attività domestiche sono segnate da una forte differenziazione sessuale, che porta gli uomini ad occuparsi della sfera pubblica e le donne di quella privata. Gli uomini non partecipano di quel sistema di trasmissioni di saperi, pratiche e conoscenze che si struttura lungo una linea femminile, madre-figlia. Le donne acquisiscono competenze, nel caso specifico della cucina, attraverso la condivisione di spazi comuni, attraverso il veder fare e il fare, attraverso l’ascolto situato, la condivisione di riferimenti simbolici e immaginativi. Il “fare quotidiano” porta alla costituzione di quella “comunità di pratiche” da cui gli uomini vengono esclusi. Il legame con la cucina del paese di provenienza, per gli uomini è legato a ricordi dell’infanzia, a odori, a sapori, a colori che nel tempo hanno contribuito a formare un gusto alimentare, uno stile di alimentazione. Molto spesso, la condizione di migranti pone gli uomini nella necessità di dover pensare in prima persona alla cucina e, quindi, di doversi formare una competenza. Questa si viene a comporre a partire da ricordi (dall’aver visto fare), ma anche accostando cibi e spezie sulla base del gusto acquisito, o sperimentando procedimenti di cottura che non costituiscono il campo del loro “saper fare”, ma si presentano in una forma frammentata, non consolidata dall’esperienza. La possibilità di dare un senso organico all’esecuzione, che ne permette la riuscita, viene raggiunta attraverso i consigli pratici che provengono da parenti femminili, madre o sorella, interpellate all’occorrenza. Si vengono a definire nuove “località di pratiche” dislocate, che mettono assieme in modo frammentato saperi e abilità diversificate. Le pratiche alimentari diventano pratiche di costruzione di soggettività che ridisegnano nuovi rapporti di potere all’interno della famiglia, della parentela, e del rapporto con il paese di provenienza.

Tajine di pesce – Mario Traina
Il cibo, poi, costituisce un canale privilegiato con la memoria, con il ricordo affettivo, con la famiglia. Lo spiega bene Deborah Lupton (1999: 85).
Il cibo agisce come “deposito” di significato, serve come giacenza di avvenimenti del passato individuale di una persona. (…) Il cibo attiva la nostalgia serve a celare la differenza, il paradosso e i conflitti, perché si ricostruisce un passato armonioso.
Le testimonianze, però, parlano ancora più chiaro. Il cibo di casa riveste un forte valore affettivo e per molti è importante approvvigionarsi in Marocco o presso commercianti che forniscono prodotti della madrepatria qui in zona, per quanto possibile.
“Ah, il cibo. Il cibo dell’infanzia ti manca sempre. Ma non è che quando mangio il cous cous comincio a pensare al Marocco. In ogni caso mangio principalmente piatti marocchini. Quando ero da solo, dal Marocco non portavo su nessun prodotto. Adesso portiamo cose che servono alle donne. Perché loro conoscono solo quella cucina là. Fino a qualche anno fa, quando eravamo solo io e mia moglie il sabato andavamo a Torino, a Porta Palazzo, e facevamo la spesa là. Ora con i figli è troppo complicato. Acquistiamo principalmente al supermercato qui a Dogliani o nei dintorni”. (H. 44 anni, uomo, cittadinanza italiana, a Dogliani dal 1989, sposato con 3 figli).
“Dal Marocco portiamo olio, olive. Andiamo anche noi a comprare la farina e i cereali al mulino di Magliano [Alpi]. Lì vanno tutti i marocchini: si trova il cous cous, lenticchie, avena, semola, grano duro. È conveniente, costa meno. Adesso i proprietari si sono riforniti di tutti i prodotti che comprano i marocchini. Vanno tantissimi marocchini da tutti i dintorni, il sabato c’è la coda. La carne la compriamo dal macellaio halal ad Alba o Bra. Prima la compravamo a Dogliani. Andiamo sia in paese, ma anche nei supermercati fuori. Verdura e frutta la prendiamo nei supermercati o al mercato”. (A. 63 anni, uomo, in attesa di cittadinanza italiana, sposato, 5 figli).
“Nelle feste tradizionali faccio i dolci e le zuppe tradizionali per il Ramadan. Il venerdì normalmente si fa il couscous, ma qui si lavora e quindi lo facciamo di domenica. I bambini amano sia la cucina marocchina che quella italiana. Noi facciamo la spesa in giro, dove ci sono le offerte. Andiamo anche a Torino, ho una nipote che abita lì e allora spesso vado il sabato a trovarla. Andiamo dal mercato dei contadini, per esempio un certo tipo di rape. Per esempio se mio fratello viene in Italia me le porta. Dal Marocco portiamo l’olio di oliva, lo ‘smen’ [il burro rancido usato per condimenti]”. (N. 36 anni, donna, sposata con due figli).
“Il cibo marocchino è importante: in casa si mangia un 80% marocchino e un 20% italiano. Per noi è molto importante portare prodotti dal Marocco come le spezie, anche se io qui faccio un piccolo orto nel giardino del palazzo dove abitiamo. Cosa coltivo? Erbe aromatiche e le verdure che servono per la cucina marocchina come menta, verbena, coriandolo, pomodori, zucchini, angurie. Dal Marocco portiamo le spezie, olio, olive in salamoia, limoni in salamoia. A Bra compriamo la carne halal, ma anche salumi halal che arrivano dal Marocco o dalla Francia. Anche noi prendiamo il cous cous, le farine, i cereali e ceci al mulino di Magliano Alpi”. (H. 38 anni, donna, sposata con due figli).
“La farina la prendiamo al mulino di Magliano Alpi che è di una signora italiana che fornisce tutti i marocchini della zona. Compriamo tutto lì: farina di grano duro per pane, cous cous, belboula (avena), pasta, lenticchie, fagioli, ceci, mandorle, noci. Il sabato vengono tutti i marocchini da Dogliani, Carrù, Mondovì. C’è sempre la coda. Per i prodotti tradizionali dobbiamo andare fuori Dogliani, a Bra o Mondovì.
Compriamo la carne a Benevagienna da un italiano che dice che è halal. La compriamo ogni 15 giorni, il sabato generalmente: 4-5 chili e 2 chili di carne macinata. Dal Marocco invece portiamo spezie, olio d’oliva olive, limoni sotto sale, smen [il burro rancido]”. (S. 39 anni, donna, sposata con H. 44, 3 figli).
“Non mi manca il cibo marocchino, perché trovo quasi tutto quel che mi serve qui. Acquisto la carne halal a Bra, poi le spezie le prendo quando vado giù. Altrimenti vado al discount. Faccio il pane in casa, la farina la compro al supermercato. Non ho il forno a gas marocchino, uso il forno elettrico della cucina. Trovo persino le spezie qui. Però certe spezie sono migliori e le compro giù. Persino lo zucchero è migliore, quello in cubetti. Lo faccio arrivare dal Marocco. In casa preparo pane e dolci”. (N. 36 anni, donna, sposata con due figli).
“Nella nostra zona [Erfoud, ai confini con il deserto algerino] è tipico un pane ripieno carne tritata, carote, cipolle, prezzemolo, uova sode: si chiama hobs duaz. Il cous cous lo faccio il venerdì, altri lo fanno la domenica. Cuciniamo anche italiano: facciamo pasta con il sugo, la pizza. Poi prepariamo anche verdure e insalata. La carne la compriamo dal macellaio halal ad Alba. Più o meno tutte le settimane, principalmente vitello. Il montone invece lo prendiamo per la festa. Per la menta andiamo all’OrtoBra dove ci sono prodotti internazionali.
Nella nostra cittadina è tipico un melone molto buono: il terreno è fertile laggiù, coltiviamo melograno, fave, albicocche, uva, pomodori, fichi, mandorle, datteri. Il dattero è il frutto più famoso, si raccoglie a settembre. Ci facciamo mandare i datteri da persone che fanno da corrieri. Da laggiù portiamo anche le spezie come cumino, pepe, peperoncino, zafferano e poi i limoni in salamoia
Qui invece andiamo a Magliano a prendere i cereali, il cous cous, sai da quel mulino dove fanno arrivare tutti i prodotti per i marocchini?”. (N. 43 anni, donna, sposata con 5 figli).
In merito alle competenze culinarie di quando erano presenti i soli immigrati uomini e come le avevano acquisite.
“Quando sono arrivato in Italia ho vissuto con mio fratello, e poi anche con l’altro fratello. Poi da solo. Cucinavamo tutti. Ci facevamo dei panini. O delle omelette, carne tritata con sugo o ancora lenticchie con carne stufata. A volte, quando non avevo tempo, mangiavo le scatolette di tonno o mi facevo fare dei panini al bar. Io ho imparato quel poco che so in cucina guardando le mie sorelle. Ma anche quando ero piccolo abitavo con mio fratello che insegnava. Ho imparato a preparare da mangiare da solo. Ricordo mia madre che faceva il pane con il lievito madre. Era un pane buonissimo. E poi il cous cous. Ma le carni arrosto, le brochette, le preparava mio padre. Poi le mie sorelle e mia madre cucinavano. Mi ricordo festa del montone. La carne la doveva tagliare lui. Lui soltanto”. (H. 44 anni, uomo, cittadinanza italiana, sposato con 3 figli).
“All’inizio abitavo a Lesegno con amici (eravamo in 7 o 8), tutti uomini. C’era chi mangiava fuori, chi comprava panini, chi le scatolette, qualcuno sapeva cucinare la carne. Io mi arrangiavo: cucinavo carne, patate, carote. Provavo e imparavo. Uno aiutava l’altro. Io volevo però rispetto, e se trovavo gente che non collaborava, preferivo cambiare inquilini”. (A. 63 anni, uomo,in attesa di cittadinanza italiana, sposato, 5 figli).
Infine, in riferimento ai gesti culinari praticati ancora oggi dagli uomini, in particolare relativamente alle feste religiose.
“Io mi occupo di tagliare e pulire il montone. Sembra un lavoro troppo duro per le donne”. (H. 44 anni, uomo, cittadinanza italiana, sposato con 3 figli).
“Macellare il montone è tipico dell’uomo anche se io aiuto a tagliare i pezzi. Uccidere lo fa il marito” (H. 46 anni, donna, con cittadinanza italiana, sposata con due figli).
Un lento processo di ibridazione gastronomica, dovuto soprattutto alle richieste sempre più “italiane” dei figli, sta cambiando il menù e le consuetudini. Sia gli uomini che le donne sono concordi nel riconoscere l’avanzare del gusto italiano nelle loro famiglie.
“All’inizio mangiavamo molto di più marocchino io e lei soli. Da quando ci sono i figli è diverso”.
“Più pasta, più pizza, all’italiana. A me piace cucinare per quando siamo tanti, per esempio il couscous. Faccio il pane in casa, con il forno marocchino. Come tutti qui.” (A. e H. 48 e 46 anni, sposati con due figli).
“Cucino cibo italiano, la pasta (penne, lasagne, pasta con verdure). Prima di venire qui ho vissuto per un anno con una famiglia italiana, amica di mio fratello, che mi ha ospitato. Io ho imparato da loro a cucinare”. (N. 36 anni, sposata con due figli)
“Normalmente cucino marocchino, ma ho imparato a fare la pizza che piace tanto ai miei figli”. (H. 62 anni, madre di 5 figli e moglie di A., 63 anni,).
La giornata delle donne è quasi sempre scandita dai compiti domestici, legati principalmente alla preparazione del cibo. I ruoli sono ormai chiari: l’uomo al lavoro fuori casa, la donna dedita alla cura dei figli e della casa.
“La mattina mi sveglio alle 6, preparo colazione per quelli che devono andare a lavorare. Faccio il pane, le ‘msemmen’ tipo [crêpes di pasta sfogliata cotte in padella].
Il martedì vado al souk, al mercato, con le altre donne marocchine. Nel pomeriggio fino a sera andiamo ai giardini dove ci ritroviamo per chiacchierare e far giocare i bambini o facciamo delle passeggiate. Per pranzo cucino carne con patate e carote, pollo e la domenica il cous cous. Faccio anche la trippa. Abbiamo una famiglia di amici che vive a Ceva e con la quale ci visitiamo a turno la domenica. Sì, ho insegnato a cucinare a mia figlia, perché deve saperlo fare. Ai maschi (risata), ai maschi no. Non sono capaci”. (H. 62 anni, donna, 5 figli e moglie di A., 63 anni,).
“Dove ho imparato a cucinare? Non da mia madre, ma dalle sorelle. Io sono la più piccola, ho preso dalle mie sorelle. E poi qui in Italia ho imparato la cucina italiana.
A mia figlia [la bambina ha 5 anni] voglio insegnare perché ogni donna deve essere una brava cuoca. Al figlio maschio non insegno, perché mi sembra una cosa un po’ strana che impari a cucinare. Anche se lui è molto curioso, e vuole venire in cucina con me per vedere cosa preparo. Io non voglio perché mi sembra una cosa strana. Pensa che trovo tutto messo a posto e in ordine!”. (N. 36 anni, donna, sposata con due figli).
“Al mattino mi alzo alle 6, preparo colazione per figli e marito, poi dalle 9 alle 12 vado ad assistere un anziano, alle 12,30 gli preparo e gli servo il pranzo e poi torno a casa. Più tardi nel pomeriggio torno da lui e ci resto fino all’ora di cena. A casa preparo il pane due volte la settimana. Ho imparato a cucinare da mia suocera, e ora insegno a mia figlia. Cucino i piatti tradizionali, come tajine, cous cous, pollo con verdure, pesce, carne alla griglia, ma anche vari tipi di pani e di dolci.
Per la festa del montone compriamo l’agnello in valle Stura, a Demonte, dove abita il fratello di mio marito. La spesa grande la facciamo nei supermercati fuori Dogliani, una volta al mese”. (H. 38 anni, donna, sposata con due figli).
“Al mattino mi sveglio alle 6 e preparo colazione, poi preparo i vestiti da lavoro per mio marito, poi faccio colazione con la figlia mediana. Alle 7 sveglio il figlio minore per andare a scuola. Quando torno metto in ordine la casa e inizio a cucinare: altrimenti mi fermo tornando a casa da scuola per fare la spesa. Pranziamo a turni: il primo con marito e figlio alle 12,30, poi alle 14,30 arrivano da scuola le altre figlie. A pranzo cosa mangiamo? Per forza la pasta, perché la vogliono i figli, con sugo, tonno o pesto. E dopo, carne con verdura stufata, con patate, olive e piselli o carote.
A volte il pesce al forno. E poi la frutta. Per cena: zuppe con cereali come la balboula di avena. D’inverno faccio l’harira o il minestrone di verdure.
Ho imparato a cucinare da mia mamma. Poi quando arrivata qui mio marito mi ha insegnato a fare la pasta. Ora io insegno a cucinare alle mie figlie: chiedo di aiutare, a loro piace fare il pane”. (S. 39 anni, donna, sposata con H. 44, 3 figli).
Per le donne, inoltre, un significativo legame con il cibo e le tradizioni di casa è favorito quotidianamente dalla televisione. Negli ultimi anni, infatti, sono nate numerose trasmissioni televisive dedicate alla gastronomia che sono seguite via satellite dalle massaie marocchine in Italia ed Europa. In special modo mi voglio soffermare su due programmi molto popolari sul canale satellitare 2M, che è perennemente acceso in ogni casa marocchina doglianese: “Ch’hiwates m’âa Choumicha” e “Ch’hiwates Bladi” condotte dalla chef e presentatrice Choumicha Acharki (Abbona 2007 e 2009)[1]

Insalata di pomodori – Mario Traina
La prima trasmissione si svolge in studio, dove la cuoca prepara ricette moderne o tradizionali rigorosamente senza guanti, mentre la seconda si sposta in diverse regioni del Marocco, dove Choumicha, abbigliata con la classica jallaba, incontra anziane donne depositarie dell’autentica cultura gastronomica del paese e rispettosamente le affianca nella preparazione di piatti fondamentali (…).
Con fare leggero e disinvolto, dialogando in arabo dialettale marocchino, Choumicha ha portato in video i saperi femminili del Maghreb fatti di tempi lunghi e laboriosa manualità, accanto alla freschezza di nuove ricette o rivisitazioni di piatti classici della cucina internazionale (…).
Ha creato un canale affettivo e della memoria – dando spazio in tv alla cucina del bled, del paese natio – con quei milioni di nuovi cittadini europei originari dell’Africa del Nord che vivono con nostalgia la loro dimensione transnazionale. Ma anche è entrata in contatto con le sempre più numerose giovani donne dei milieux urbani – in Marocco e in Europa – che si dividono tra casa e lavoro e che non possono passare ore in cucina. (…).
Se è conscia di questo ruolo quasi didattico, o meglio dell’impatto sentimentale sulla memoria del paese natale che suscita nella comunità espatriata, è una questione che sollevo immediatamente. «Sì, me ne rendo conto dalle e-mail, dai contatti e dagli incontri che faccio nei miei viaggi in Europa». Difatti le racconto che le mie amiche marocchine, quando hanno saputo che l’avrei incontrata, hanno preteso che la fotografassi e che le portassi i loro saluti e complimenti. Durante i bui e deprimenti inverni del nord, Ch’hiwates m’âa Choumicha tiene compagnia a tutte quelle donne che passano gran parte della giornata in casa, mentre marito e figli sono fuori al lavoro o a scuola: l’arabo colloquiale, le ricette della tradizione, i panorami del cuore sono una piccola pillola che prova a curare il male del sentirsi lontano dal luogo natio.
Bibliografia
- Abbona A. (2007), Chef Osama plus charmant de Vissanì, pagg. 72-75 in “Slow Food” n° 24 , marzo 2007, Bra.
- Abbona A. (2009), Le delizie del piccolo sole, pagg. 140-142 in “Slow Food” n° 42 , ottobre 2009, Bra.
- Ambrosini M. (2008), Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali, Il Mulino, Bologna
- Cesari J. (1997), Les réseaux transnationaux entre l’Europe et le Maghreb : l’international sans territoire, in Revue européenne de migrations internationales, vol. 13, n. 2.
- Cesari J. (2005), La leadership islamica in Europa tra fondamentalismo e cosmopolitismo, in J. Cesari – A. Pacini (a cura di), Giovani musulmani in Europa, Edizioni Fondazione Agnelli, Torino
- Lupton D. (1999), L’anima nel piatto, Bologna, Il Mulino
- Mernissi F. (1996), La terrazza proibita. Vita nell’harem, Giunti, Firenze.
- Parisi R. (2006) Il linguaggio del cibo. Strategie quotidiane di comunicazione nelle coppie italomarocchine, in “Atti del X Congresso Nazionale AISEA Cibo e alimentazione. Tradizione, simboli, saperi” 5,6,7 luglio 2006 Roma,