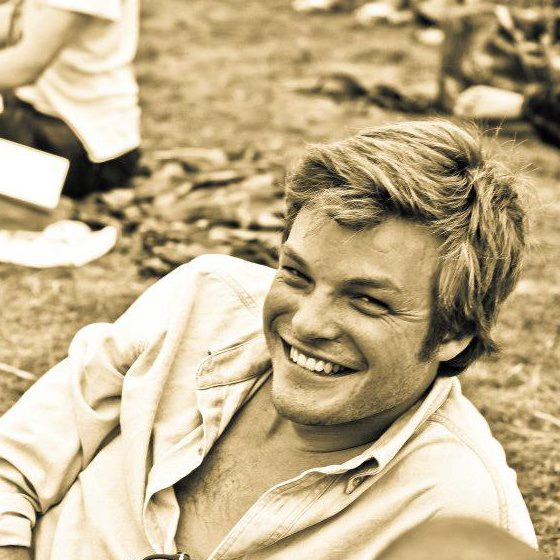Si è inaugurato a Pollenzo il Laboratorio di Creatività Gastronomica, un progetto ambizioso. Il primo appuntamento è stato dedicato a “I linguaggi del vino”. Questo incontro ha visto coinvolti alcuni esperti e sei fortunati studenti della triennale.
Ferro e burro, leggera nota acrilica, grassezza equilibrata da acuta nota acida. Spremuta di erbe aromatiche, fieno secco, finale pennellato di note salmastre. 93/100. Che?
Assuefatti dai sensori di maraschino e ribes, accecati dal tentativo di trovare la perfetta limpidezza, sempre alla ricerca del più armonico equilibrio, storciamo il naso di fronte ad un vino che non rientra nei parametri standard di ciò che, secondo lo storicamente recente – e un po’ troppo celebrato – metodo “sommelieristico”, è considerato un vino di qualità.
Nicola Perullo, filosofo, professore di Estetica dell’Università di Scienze Gastronomiche e direttore del nuovo Laboratorio, esprime tutto il suo disagio nei confronti di un linguaggio e di un lessico quanto mai riduttivi, incapaci di esprimere tutta la potenzialità della bevanda più apprezzata dal’umanità. Due giorni intensi di discussione, confronto tra diversi punti di vista e assaggi con l’illuminante presenza di due grandi esperti del mondo del vino: Giampaolo Gravina, vice-coordinatore nazionale della guida “Vini d’Italia” dell’Espresso, ed Emanuele Giannone, wine writer e collaboratore di varie testate, per codificare un nuovo linguaggio del vino. Questo eterogeneo gruppo è stato affiancato da Gianfranco Marrone, semiologo che insegna anche all’UniSg, la dottoressa Maria Piochi, sensorialista del Laboratorio di Analisi Sensoriale dell’UniSg, e l’ex studente e neodottore gastronomo Valerio Reale.
Il paradigma degli ultimi 60 anni – dopo la svolta industriale dell’enologia moderna – si è costituito attorno ad alcune idee e figure di riferimento: da un lato il tecnico, l’enologo, con i suoi saperi “oggettivi”; dall’altro l’esperto, il critico, visto come un santone inavvicinabile. I linguaggi del vino – tanto nella produzione che nell’assaggio – sono diventati così sempre più specialistici ed esclusivi. In particolare, la capacità di apprezzare il vino sembra essere appannaggio di coloro che detengono saperi esclusivi, legati a pratiche di apprendimento lento e costante. Il vino è stato ritenuto sempre di più un bene di lusso,un oggetto prezioso da conservare il più a lungo possibile, dimenticandosi del suo scopo primario: essere bevuto dando godimento, piacere e leggera ebbrezza.
Questo linguaggio, poi, ha creato una grammatica gustativa basata soprattutto su qualità misurabili e oggettivabili (acidità, tannini, aromi) pensando che su queste occorre fare affidamento per valutare un vino (basta vedere le schede di degustazione dell’AIS o di altre associazioni). Ci si è dimenticati, in parte o del tutto, delle qualità non misurabili, perché ritenute troppo vaghe o “soggettive” (quali eleganza, finezza, personalità, carattere, ma anche bevibilità e convivialità). È dunque accaduto, e ancora accade, che vini “estremi”, fuori dal comune (i cosiddetti “naturali”, i biologici e i biodinamici )paradossalmente considerati diversi dal “vero” vino convenzionale, vengono così tagliati fuori dalla critica o, forse peggio, vengono descritti con termini ancora più aulici ed esoterici, che tendono solo a far allontanare il neofita appassionato.
È possibile un approccio diverso, che recuperi consapevolmente questa dimensione?
Si è discusso molto di questo, a partire da una rassegna di temi affrontati dalle persone presenti e poi “messi alla prova” con un interessantissimo assaggio di 16 vini che si è svolto nel pomeriggio. Uno degli esempi in gioco, proposto da Giampaolo Gravina, è stato un approfondimento del concetto di “mineralità”, intesa come freschezza acida e sapidità, non direttamente quantificabile ma prepotentemente evocata dal primo vino assaggiato, un Saint-Aubin Premier Cru di Borgogna, che con il suo ingresso dinamico e scattante in bocca, ci ha lasciato un’immagine sbiadita ma persistente del suo territorio. Per descrivere questa mineralità e le altre qualità estetiche è necessario quindi andare oltre il lessico codificato e sterile di una degustazione “analitica”, in cui tutto è volto alla dissezione insensata di una bevanda che è invece da considerarsi nella sua integrità, fatta di territori, agenti atmosferici, persone, stati d’animo e potere inebriante e conviviale.
A partire da questo, e attraverso una serie di vini assaggiati in parte alla cieca in parte no, si è giunti alla condivisione di un aspetto essenziale: la lingua del vino è una lingua plurale. Non vi può essere un’unica grammatica e un solo lessico, ma una varietà di parole e concetti che rispondano alle diverse esigenze di relazione che si ha con il vino. Differenti modi di fare il vino chiamano in causa la possibilità di diversi modi di descriverlo e apprezzarlo, secondo tempi, modi e occasioni diverse. Un atteggiamento che, con Nicola Perullo, si potrebbe definire laico.
Una laicità che si oppone a ogni assolutismo e divinizzazione, sia della figura dell’esperto –sciamano che della tecnica e dell’enologia.