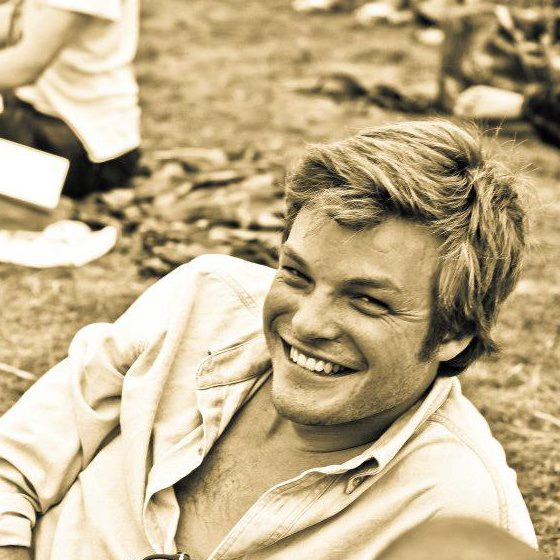All’interno del vasto e variegato genere letterario dei resoconti del “viaggio in Italia” un posto speciale – per l’originalità dei contenuti – spetta ad un’opera poco nota, ma assai interessante, scritta dall’agronomo svizzero Fréderic Lullin de Châteauvieux (1772-1841), amico di Madame de Staël e membro del cosiddetto ‘Gruppo di Coppet’.
Si tratta delle Lettres ecrites d’Italie en 1812 et 1813, pubblicate a Ginevra nel 1816 (e successivamente in edizione inglese, stampata nel 1819 a Norwich, con il titolo di Italy, its agricolture), in cui l’autore non parla, come spiega nell’introduzione, “né di edifici, né di monumenti, né di città, né delle arti che li hanno abbelliti”. Oggetto della sua trattazione vuole infatti essere “la storia rustica dell’Italia”. Ecco quindi che dopo aver valicato le Alpi e data una fugace occhiata a Torino e Moncalieri, Lullin si reca a Santena, prima tappa del suo viaggio in Italia, dove soggiorna fra il maggio e il luglio 1812, esattamente duecento anni or sono. Lullin adottò nel suo resoconto di viaggio la forma epistolare, una formula che ebbe un notevole successo nella letteratura di viaggio: si pensi ad esempio alle Lettere brandeburghesi dell’abate Denina. Lullin nella sua seconda lettera, scritta da Asti il 10 luglio 1812, descrive con dovizia di particolari una cascina santenese di cui non fa il nome, ma che dice essere parte di un più ampio “domaine”, composto da quattro cascine condotte a mezzadria, poste a ridosso di un canale irriguo ed un castello (verosimilmente Ponticelli o San Salvà). La cascina visitata da Lullin – un vasto edificio a corte chiusa – viene portata a modello di tutta l’agricoltura della nostra regione, anzi più in generale di un vasto territorio che il Marchese di Châteauvieux chiama Lombardia, termine con cui immagino intendesse indicare in modo estensivo l’intero territorio della pianura padana: le cascine “sono così simili in tutto il Piemonte, che questo esempio vi darà un’idea completa di tutte”. “Questa cascina, come tutte quelle della Lombardia – prosegue lo scrittore – offre una ampiezza e ricchezza di edifici sconosciute in quasi tutti gli altri paesi d’Europa. Costruita in mattoni rossi, riunisce la solidità all’eleganza, essa presenta nella sua forma regolare qualche cosa di rustico, che le conserva il suo aspetto campestre”. La descrizione di Lullin si addentra poi sui singoli particolari della cascina di Santena: “i muri esterni della fattoria sono tutti ricoperti di viti le cui uve danno un vino cattivo, ma che il mezzadro consuma e che l’abitudine gli fa sembrare passabile”. Il sistema di affittanza agraria è al centro dell’attenzione di Lullin: “in ognuna di queste aziende vive una famiglia di mezzadri che spesso abitano nella stessa azienda da padre in figlio, per loro è come una antica patria e non pensano molto a rinnovare il contratto, che si perpetua di generazione in generazione, alle stesse condizioni, senza scrittura e senza registrazione”. Dalla cascina lo studioso elvetico si sposta ai campi: dapprima descrive il giardino, di cui nota le piante di fichi e i fiori, per poi passare alla descrizione dei coltivi. Si tratta di un’azienda di sessanta giornate, di cui quindici destinate a pascolo, dieci a trifoglio, la restante parte a seminativo. Alcune indicazioni ci lasciano immaginare il paesaggio agrario che caratterizzava Santena negli anni della dominazione napoleonica. I campi si presentavano delimitati da file di alberi: gelsi e ciliegi, questi ultimi con vite maritata, una tecnica colturale che consentiva di moltiplicare il raccolto “senza occupare spazio”. La cascina aveva anche una bella stalla, con le volte imbiancate a calce, accorgimento che serviva a far sì che “la polvere non cada mai sugli animali”. La dotazione di animali comprendeva 8 buoi e 13 fra vacche e vitelli (di razza Querei, destinati prevalentemente alla produzione di carne), oltre ad un cavallo “malandato” che veniva impiegato esclusivamente “per andare al mercato e battere il grano”, operazione quest’ultima che all’epoca ancora veniva effettuata con il cosiddetto “rubat”, un apposito rullo scannellato (se ne può osservare una efficace immagine scattata nel 1922 a Castelnuovo don Bosco nel volume di Paul Scheuermeier, Il Piemonte dei contadini (1921-1932), a cura di Sabina Canobbio e Tullio Telmon, Ivrea, Priuli & Verlucca, vol. II, p. 89).
Da Santena il nostro autore prosegue il suo viaggio verso Asti e poi da qui risale alla Mandria di Chivasso, un grande podere modello fondato da Carlo Emanuele III fra il 1764 e il 1766, nato per l’allevamento equino, e poi successivamente destinato a quello delle pecore merinos. Da Chivasso il nostro viaggiatore proseguì il suo itinerario agrario attraverso Piacenza, Parma, Genova, Sarzana, Firenze per poi raggiungere Roma, Napoli e Salerno: un lungo viaggio attraverso alcune fra le più importanti realtà agricole italiane che lo impegnò fino al novembre dell’anno successivo quando rientrò in Svizzera.
Chi volesse ripercorrere, duecento anni dopo, il viaggio “rustico” di Lullin, andando alla ricerca della cascina-modello da lui visitata a Santena, potrà comunicare eventuali segnalazioni utili alla sua esatta individuazione scrivendo a g.fassino@unisg.it
Gianpaolo Fassino