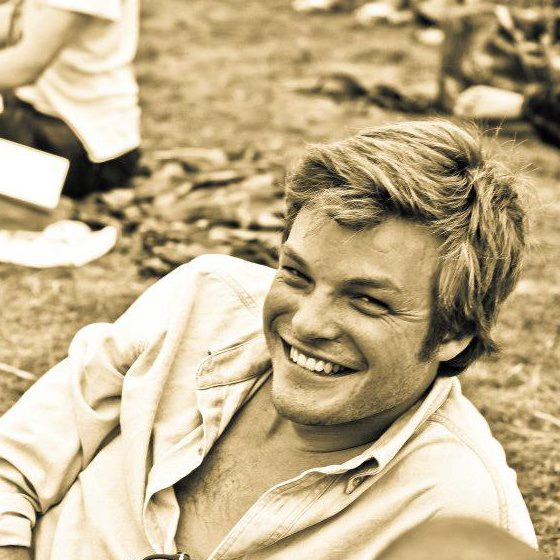Vuole questo essere un conciso e asettico tentativo di ciò che, in modo sintetico e (si spera) chiaro, è il mondo del biologico, dalle origini ad oggi, dalla terra al packaging.
L’agricoltura biologica è un sistema di produzione che, in modo sinergico, cammina sulle due gambe del rispetto dell’ambiente e dell’uomo. L’apparente ossimoro “sistema di produzione/volontà ambientale e filantropica” si scioglie alla luce degli ultimi decenni di esperienza bio, quando la correlazione positiva tra le due variabili si manifesta in modo palpabile. Questo legame scorre sotto il suolo coltivato secondo metodi rispettosi della fertilità, emerge della terra nelle spoglie della biodiversità, si trasforma in linfa per il benessere animale e si lega direttamente all’uomo in ogni fase dell’iter di produzione-trasformazione-distribuzione-consumo.
L’eco-agrosistema biologico non va riduttivamente considerato come un rewind ai tempi dell’agricoltura tradizionale: sono le chances a fare la differenza. Chiariamo che il mondo biologico non può essere inteso nei termini di un idilliaco ritorno al passato, quando l’utilizzo della chimica rappresentava un ostacolo strutturale, ma come una scelta consapevole che certo, osserva con ammirazione il modus operandi naturale tradizionale, ma lo veste di significati nuovi, fatti di innovazione, criticità e coscienza. Tra gli illuminari dell’AB nel panorama internazionale autori come Fukuoka, Sir Albert Howard, Lemaire e Bouchet, Jerome Irving Rodale, Bill Mollison e David Holmgren, ma non è immune a queste tematiche anche la sensibilità accademica dei nostrani Alfonso Draghetti e Francesco Garofalo. Ognuno di questi contributi ebbe nel mondo enorme risonanza, ma è con il proliferare di abusi alla terra sempre più brutali che l’eco di queste voci risuona chiaro e forte.
Nella fase più tenera, l’AB rappresentava una forma quasi eroica di agricoltura: guardando alla realtà italiana, chi per primo mise in campo la teoria fu realmente mosso da una vocazione. I pionieri vissero una vita non troppo distante da quella degli eremiti: sconnessi logisticamente dai poli di commercio, si rapportavano ai primi mercati biologici urbani non certo affollati e non ricevendo alcuna forma di sostegno in grado di supportare l’incredibile sforzo di avviare produzioni biologiche in aree marginali. Il processo di riconoscimento e istituzionalizzazione del biologico in Italia segue quella duplice logica che si muove su due noti binari: è il mercato a stabilire l’urgenza della regolamentazione; a comprendere la portata dei fenomeni arrivano sempre prima i nostri vicini. L’Ifoam (International Federation of Organic Agriculture Movements) nasce nel 1972 sotto la spinta dell’associazione francese Nature & Progrès con l’obiettivo di avvicinare in un’ottica internazionale tutti gli attori operanti nel settore del biologico e definire alcune linee guida comuni. La risposta italiana, inizialmente frammentata su livelli locali e regionali, sarà quella della fondazione dell’AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) esattamente un decennio dopo.
Ma torniamo sul primo binario, quello economico. Il mercato europeo (specie ancora una volta quello del Nord) palesa una larga schiera di consumatori disposti a spendere di più pur di consumare alimenti percepiti come sani e qualitativamente ed eticamente preferibili. Ancora un salto decennale per assistere alla prima regolamentazione a livello europeo: il 24 giugno 1991 nasce il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Il motivo della normalizzazione non è certo celato e considerando che « i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici» e che «questo fenomeno sta quindi creando un nuovo mercato per i prodotti agricoli e che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato », la necessità è quella di stilare delle norme capaci, da un lato, di sostenere gli sforzi degli operatori nel settore (in linea con la politica agricola comune), dall’altro, quella di offrire una garanzia ai consumatori stilando un primo elenco di tutto ciò che è lecito o meno all’interno della filiera di produzione. Ogni step risulta soggetto a controlli che si susseguono in modo piramidale, nel caso italiano: alla base il lavoro svolto dagli organismi di controllo privati verso i produttori, che rispondono a loro volta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) che, in ultima istanza, è assoggettato all’UE. Il meccanismo di controllo diventa formalmente ancora più rigido e serrato con la sostituzione del Reg. 2092/91 dai Reg. CE 834/07 e 889/08 e a livello nazionale con il D.M. 18354/09. Raggiungendo la maggiore età, la normativa sulla produzione biologica si arricchisce e s’infoltisce toccando in misura dettagliata aspetti precedentemente tagliati fuori: il divieto per incompatibilità dell’utilizzo degli OGM; l’acquacoltura, settore in crescita esponenenziale che vede una correlazione negativa tra l’aumento del consumo di pesce e la diminuzione della pescosità dei mari; il vino, che fino a qualche anno fa poteva essere disponibile unicamente come “vino da uva da agricoltura biologica”, può essere ora commercializzato come “vino biologico”. Conseguente ancora una volta all’impatto del bio sul mercato europeo è stato, a partire dal 1° luglio 2010, l’uso del nuovo logo e del sistema di etichettatura come obbligatorio per tutti i prodotti biologici realizzati nel rispetto della normativa comunitaria. La funzione è quella di assicurare al consumatore che il prodotto acquistato sia stato ottenuto seguendo tutti i dettagli la normativa europea, o nel caso di prodotti importati, secondo regole equivalenti o altrettanto rigide, garantendo in ogni caso una completa tracciabilità di filiera del prodotto. Se anche il discorso qualitativo ha trovato posto all’interno della normativa europea, stabilendo nel Regolamento CE n. 834/2007 che uno degli obiettivi della produzione biologica è quello di dare prodotti di alta qualità, ciò che normativamente esula, ma che dovrebbe risultare implicito (e che di fatto viene esplicitato tra gli standard Ifoam), è il valore aggiunto sociale e umano dell’AB, che anche per questo motivo si pone come uno straordinario modello emulabile dai paesi in via di sviluppo ma che attualmente, in molte realtà produttive biologiche, assume forme e dimensioni che sembrano oscurare quest’aspetto evocando piuttosto l’immagine di un efficiente sistema produttivo industriale.
Possiamo ancora una volta guardare all’Italia come esempio paradigmatico: ad oggi, la superficie coltivata secondo il metodo biologico è di 1.317.177 ettari dove gli orientamenti produttivi sono principalmente rivolti ai pascoli, al foraggio e ai cereali e dove la dimensione media della superficie biologica delle aziende, pari a 18 ettari, è oltre il doppio di quella delle aziende agricole in generale, con un valore di 7,9 ettari. Ultima ma non trascurabile è la questione del legame tra il prodotto biologico e il suo territorio d’origine. Nell’ottica della Commissione Europea la riconducibilità territoriale è una mera espressione di tracciabilità per un consumatore immerso nella pluralità dell’offerta globale. Ciò che si trascura sono tutte quelle dimensioni legate alla valorizzazione e alle esigenze locali e che si manifestano nel concetto del bioregionalismo e nei circuiti dei Gruppi di Acquisto Solidale. Oggi, sulla cresta dell’onda biologica, ciò che possiamo auspicare è che la virtuosità del processo non scada in puro trend e che, partendo dalle sue valide basi, vada a sensibilizzarsi arricchendosi pienamente di queste più recenti e delicate tematiche. Ma l’augurio più grande che si può rivolgere al bio è questo: fatti conoscere, comunicati, renditi noto e trasparente come un amico di vecchia data, come il membro di una famiglia talmente larga da farci sembrare tutti cugini.
————————————
1 Dati aggiornati forniti dal Sinab, http://www.sinab.it/content/bio-statistiche